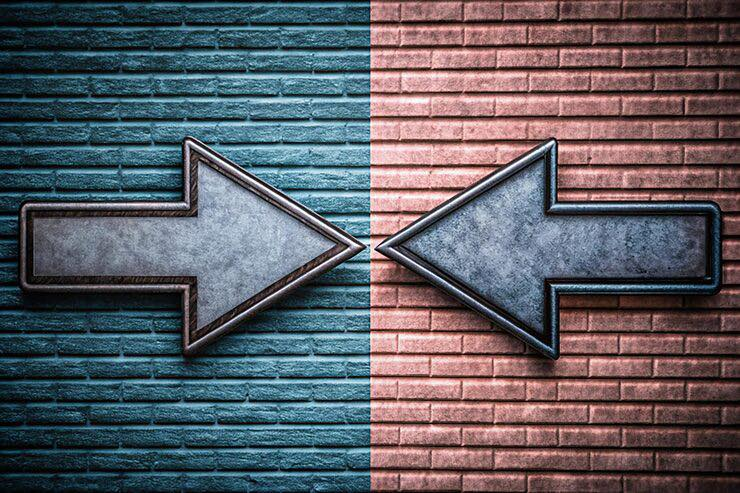Daniele Trabucco
La dicotomia tra “destra” e “sinistra” costituisce uno degli schemi interpretativi più radicati nel linguaggio politico contemporaneo. Essa affonda le proprie radici storiche nella Francia rivoluzionaria del 1789, quando nell’Assemblea Nazionale i sostenitori del veto regio e dell’ordine tradizionale si collocavano a destra del presidente, mentre i fautori di un potere popolare più radicale prendevano posto alla sua sinistra. L’origine spaziale e contingente di questa opposizione segnala già la natura convenzionale e contingente di una polarità che, pur trasformata e riadattata nel corso dei secoli, continua a esercitare una forza classificatoria sugli attori politici e sull’opinione pubblica. Ciò che appare come differenza sostanziale è, in realtà, il portato di una stessa matrice culturale: la modernità politica, con le sue promesse emancipative e le sue aporie strutturali. Destra e sinistra, nelle loro versioni contemporanee, si presentano come opposti dialettici, ma entrambe affondano nella medesima matrice illuministica e contrattualistica che riduce la politica a gestione della convivenza e amministrazione del conflitto, perdendo la dimensione teleologica che la tradizione classica le riconosceva. Le differenze si registrano sul piano delle preferenze contingenti: da un lato, l’enfasi sulla libertà economica e sulla difesa di identità culturali tradizionali; dall’altro, l’insistenza su redistribuzione, diritti individuali e pluralismo.
Eppure, il terreno è comune: l’uomo ridotto a soggetto autosufficiente, sciolto da legami ontologici, la comunità trasformata in mera somma di individui, lo Stato eretto a garante di diritti mutevoli e spesso contraddittori. In questa prospettiva, tanto la destra quanto la sinistra si trovano prigioniere delle stesse aporie: l’impossibilità di fondare un vero ordine politico sul consenso mutevole, la contraddizione insanabile tra volontà generale e bene comune, la tensione tra libertà assoluta proclamata e necessità di un potere sempre più pervasivo che regoli le infinite pretese individuali. La presunta differenza sui cosiddetti temi etici, spesso utilizzata come discrimine essenziale, si rivela in molti casi solo apparente.
Se è vero che alcuni settori della destra tendono a presentarsi come custodi di valori tradizionali, il terreno effettivo sul quale si gioca la partita rimane quello dell’individualismo moderno: la stessa difesa di princìpi morali non è fondata su un ordine oggettivo, ma su preferenze sociologiche e culturali, pronte a essere sacrificate di fronte alla logica del mercato o alla ragion di Stato. Si pensi alla vicenda dell’aborto: la destra parlamentare non ha mai messo realmente in discussione la legge ordinaria dello Stato n. 194/1978, la quale ha introdotto l’interruzione volontaria di gravidanza come diritto soggettivo, limitandosi a rivendicare in maniera episodica il sostegno ai consultori o la promozione della natalità, senza mai proporre un ritorno a un quadro giuridico che tuteli in maniera piena la vita nascente.

Di fatto, la norma viene accettata come elemento intangibile del compromesso costituzionale, segno che la pretesa “contrarietà” è più testimoniale che normativa. Analogamente, di fronte al tema del suicidio assistito, laddove la Corte costituzionale (sent. n. 242/2019) ha aperto spazi significativi alla non punibilità dell’aiuto al suicidio, la destra si è limitata a esprimere dissenso morale, addirittura (almeno una sua parte) ha proposto progetti di legge di inziativa parlamentare per tradurre in termini di diritto positivo le indicazioni del giudice costituzionale per evitare, dicono, fughe in avanti (poveri illusi che dimenticano come Palazzo della Consulta abbia snaturato la legge formale n. 40/2004 sulla fecondazione medicalmente assistita). La sinistra, dal canto suo, radicalizza l’istanza emancipativa, spingendo oltre i confini della natura stessa ciò che considera diritto, ma lo fa muovendosi sullo stesso piano orizzontale della destra: quello di una politica senza trascendenza, incapace di oltrepassare il paradigma moderno dell’autodeterminazione.
Entrambe, così, si mostrano come variazioni interne al medesimo orizzonte, differenze di grado più che di sostanza, segni speculari di un unico processo di secolarizzazione. Occorre, allora, pensare la politica non come amministrazione delle contrapposizioni o come mediazione degli interessi, ma come arte regale, nel senso antico e classico del termine. La regalità politica, lungi dall’essere la caricatura assolutistica che la modernità le ha attribuito, è l’arte che ordina l’umano verso il bene comune, inteso non come semplice somma di beni individuali, ma come compimento della vocazione propria della comunità. Essa richiede una concezione della legge come misura razionale conforme alla giustizia naturale, non come atto di volontà sovrana. È un sapere prudenziale, simile a quello che Omero riconosceva nei re achei, i quali, ispirati da Zeus, erano chiamati non a imporre la propria volontà, ma a custodire il kosmos della città e ad armonizzare gli uomini tra loro e con il divino.
Recuperare questa dimensione significa superare la dicotomia destra/sinistra come schema inadeguato e storicamente contingente, per riconoscere che la politica è, in verità, una via regale: arte del governo come cura dell’ordine, esercizio della sapienza pratica che si radica in un orizzonte di senso trascendente. Solo così si evita la caduta nell’illusione moderna di ridurre la convivenza a tecnica, il diritto a volontà, l’uomo a monade isolata. La politica, restituita al suo carattere nobile, può tornare a essere non la gestione di conflitti tra individui, ma l’arte di condurre la comunità verso la giustizia, verso il bene e verso la pace, secondo l’armonia che già Omero scorgeva nell’equilibrio del cosmo e nella voce dei re che parlavano come interpreti del divino.